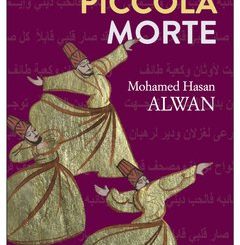Il nome delle cose

di Jorida Dervishi Mbroci
La piazza era vuota. Restavano solo nastri rossi e viola che il vento trascinava piano lungo i gradini. Un cartello abbandonato, rovesciato, mostrava a metà una parola: “libertà”. Azzurra si chinò per raddrizzarlo, come se sistemare quel pezzo di cartone fosse un modo per non lasciare che il senso di quelle lettere si disperdesse nell’aria. Il giorno prima, lì, c’era stata una manifestazione per i diritti delle donne. La voce collettiva aveva riempito quello spazio fino a traboccare: slogan scanditi, cartelli scritti a mano, passi decisi che battevano il ritmo di una stessa volontà. Ora, il silenzio era tornato. Ma non era pace: era l’eco di un rumore che la vita reale avrebbe presto soffocato.

Stringeva la mano di sua figlia, sentendo il calore piccolo e deciso di quelle dita. Guardandola, si chiese che mondo avrebbe trovato quando sarebbe stata grande. Non voleva che le sue scelte fossero misurate sulla pazienza o sulla rassegnazione. Non voleva che imparasse a sorridere per non disturbare, o a tacere per non provocare. Azzurra sapeva che i diritti non sono mai un regalo: sono conquiste fragili, che qualcuno cerca sempre di ridurre. E sapeva anche che, per certe ferite, non esiste una legge che basti a proteggere. Aveva visto troppe donne essere abbandonate e trattate come cose rotte, scartate quando non servivano più. Donne lasciate senza un tetto, senza soldi, senza un luogo sicuro dove respirare. Donne che, una volta finite le grida, si trovavano a dover combattere da sole la fame, la paura, la vergogna. C’erano leggi per punire un pugno o un livido, ma non per il vuoto lasciato da un amore che diventa disprezzo, da un legame che si trasforma in ricatto. Non per la solitudine di chi, dopo anni di rinunce, si ritrova senza protezione, con figli da crescere e nessuno che la guardi come un essere umano. Seduta su un gradino, lasciò che la bambina disegnasse con un gessetto trovato per terra. Cerchi, fiori, un sole storto.

Piccoli segni innocenti su pietre che avevano visto rabbia, paura, silenzio. Le venne in mente che i diritti sono anche questo: la possibilità di disegnare un fiore senza che nessuno ti dica cosa devi fare, chi devi essere, come devi stare al mondo. Ripensò a sé stessa, a quando era più giovane. Aveva confuso il rispetto con l’obbedienza, la cura con la rinuncia. Aveva accettato di essere interrotta, ignorata, messa in disparte, perché “così fanno tutti” e “non è il caso di discutere”. Poi un giorno, non ricordava bene quando, aveva iniziato a dare il nome giusto alle cose. Aveva iniziato a chiamare controllo quello che altri chiamavano amore, abuso quello che altri chiamavano carattere, diritto quello che altri chiamavano privilegio. E quando dai il nome giusto alle cose, il mondo non è più lo stesso. Perché non puoi più fingere di non sapere. Guardò la bambina che le sorrideva, orgogliosa del disegno appena finito. – Mamma, ti piace? – Molto. E sai perché? Perché è come lo volevi tu, non come ti ha detto qualcun altro. Si alzò, stringendo quella piccola mano. – Andiamo, amore. Ti insegnerò a dare il nome giusto alle cose. – Anche alle brutte cose? – Soprattutto a quelle. Perché solo così possiamo cambiarle. Camminarono via, lasciandosi alle spalle la piazza, i nastri, il cartello. Ma non la promessa che quel giorno aveva preso forma: le mani che oggi stringono la mia non avranno paura di aprirsi. Perché il silenzio, questa volta, non sarà mai più complice.